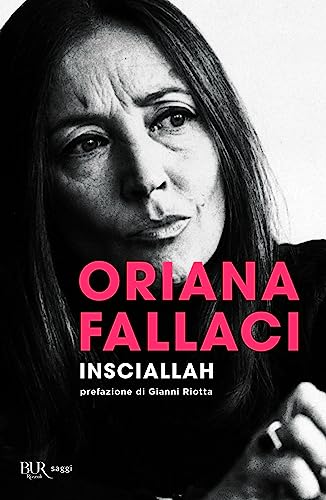Torna il film in blu-ray con la CG Entertainment
di Paolo Speranza
Foto: Lina Wertmuller premiata a Locarno

La Vela d’Argento al Festival di Locarno, dove I basilischi fu presentato in “prima” mondiale, fu il naturale e meritato riconoscimento a quell’”ottimo esordio”, come lo aveva definito nel maggio del ’63 su ‘Cinema Domani’ (che al film dedicò la copertina e ne pubblicò la sceneggiatura) Corrado Terzi, che aveva potuto vederlo in anteprima: “un’opera originale, fresca, e la rivelazione di una personalità promettente”.
A sua volta, sul ‘Calendario del popolo’ di dicembre, uno dei critici cinematografici più autorevoli, Ugo Casiraghi, commentò con un senso di gioia quasi liberatorio:
“Siamo arrivati buoni ultimi, ma siamo arrivati: anche il cinema italiano ha la sua donna regista. Si chiama Lina Wertmuller”.
Era una circostanza più che sufficiente per trasformare I basilischi in un evento, ancora prima di approdare in sala, benché non si trattasse in realtà di una “primizia” assoluta. Lo stesso Casiraghi, riprendendo un articolo scritto quindici anni prima da Glauco Viazzi su ‘Cinema’, Donne dietro la macchina da presa, citava l’interessante caso di Anna Gobbi, che nel ’48 aveva realizzato un film di avanguardia, Tre più due, e si spingeva qualche anno più indietro, nella fase finale del ventennio fascista, recuperando le figure di Pina Rossi e dell’attrice-regista toscana Marcella Albani.
Sul finire degli anni Cinquanta, inoltre, il critico del “Calendario” e de ‘l’Unità’ aveva potuto salutare con fiducia le innovative esperienze registiche di Lorenza Mazzetti, futura inventrice del “Free Cinema” inglese, e della documentarista Cecilia Mangini. “È vero però – finisce per ammettere Casiraghi – che Lina Wertmuller è la prima vera donna-regista di un film a soggetto completo”, titolo che una recente stagione di studi ha consentito di attribuire, con maggiore fedeltà alla storia, alla straordinaria (e finora unica) figura di regista-sceneggiatrice-produttrice italiana: Elvira Notari.
Prima. Nuova. Ma già padrona della macchina da presa fino ad allora solo sognata dalle cineaste italiane: “Ha impeto, vitalità, intelligenza. Certamente è nata per fare del cinema”, sentenzia due anni dopo I basilischi (su ‘L’Europeo’ del 4 aprile) un Mario Soldati forse più sorpreso che convinto, a giudicare dal tono dell’articolo.

Dopo il suo esordio, la Wertmuller non era più considerata una semplice rivelazione ma una regista dotata di una chiara personalità, sulla quale peraltro i riflettori della stampa, ben al di là delle riviste specializzate, si erano accesi prima ancora dell’uscita di I basilischi.
Donna regista e anche sceneggiatrice, per giunta sempre in pantaloni sul set: ce n’era abbastanza per incuriosire anche i lettori di ‘Gente’, uno dei settimanali più diffusi, che nel numero del 28 dicembre 1962 presentò con grande risalto, e tanto di fotografia, la “brunetta tutto pepe” e “allergica alle interviste” che si stava facendo strada nel cinema italiano, dopo anni di gavetta come autrice nelle commedie musicali di Garinei e Giovannini e poi a Canzonissima, il programma di punta della giovane Rai-Tv.
Ecco perché del film, che non aveva ancora un titolo, “si parla già – sottolinea su ‘Gente’ Anita Paglia – benché le riprese siano state terminate solo da pochi giorni, perché racconta una storia di uomini ed è stata realizzata da donne”. La Wertmuller aveva infatti voluto al suo fianco due aiuto-registe, sue amiche di lunga data: Bibi Archilao Tagliaferri e Franca Invernizzi, moglie del produttore Nello Santi.
Nel gennaio successivo anche ‘La Fiera del Cinema’, patinato e diffuso mensile di settore, dedicò un’ampia anteprima a I basilischi, focalizzando l’attenzione sull’inedita figura della regista: “L’ultimo nome venuto ad aggiungersi al lungo elenco dei registi che hanno fatto il loro esordio in questo 1962 così propizio alle ‘opere prime” – è l’incipit dell’articolo di Vittorio de Grandis I pigri giorni di un borghese del Sud – è quello di una donna: Lina Wertmuller”: un’esordiente assoluta, pressoché sconosciuta nel mondo del cinema, precisa il giornalista.

Quella novità di genere non restò confinata alle note di colore, per merito della forte personalità autoriale che la regista rivelò fin dall’esordio, con una decisa connotazione femminista. Anche in una società come quella narrata nel film, refrattaria al progresso e men che mai all’emancipazione della donna, la Wertmuller riuscì a individuare – con acume e lungimiranza – in alcuni personaggi femminili i pochi barlumi di apertura e iniziativa in quel contesto così retrivo.
Si tratta di eccezioni, beninteso: nel paese dei “basilischi” le donne vivono all’insegna di una atavica e sottomessa rassegnazione, e le più giovani, che hanno come principale se non esclusivo orizzonte quello della “sistemazione” matrimoniale, sono spesso rappresentate in atteggiamenti caricaturali, talvolta con un look pre-fantozziano.
Eppure, qualche sintomo di dinamismo culturale si manifesta solo nel loro mondo, che si tratti di rare figure di professioniste (la dottoressa) o persino dell’ultima esponente dei potenti latifondisti D’Andrea, la “contessa a cavallo” un tempo temuta e rispettata dai contadini, ancorata a un retaggio feudale ma con una personalità autonoma e laica.

Anche nell’unica scena tragica del film, quella del suicidio, rappresentata dalla Wertmuller con delicata e struggente poesia, la protagonista è una donna, un’anziana vedova, ricca solo di dignità e solitudine. “È un episodio estraneo al contesto del film, poco preparato, una dissonanza; ma si osservi il modo in cui è raccontato: la carezza leggera al ritratto del marito defunto; l’inquadratura della donna che scavalca il davanzale; il contropiano dell’altra donna che assiste, atterrita, dalla finestra di fronte; il piano ravvicinato della suicida che le intima di tacere; il contropiano dell’altra donna che grida. È una sequenza brevissima ma rivela un regista”, commentò Morando Morandini su ‘Bianco e Nero’ del luglio-agosto 1963.
Per Maurizio Ponzi, su ‘Cinema 60’ dell’ottobre 1963, quel suicidio era anche una efficace metafora del “conflitto tra ciò che si è e cosa si vorrebbe essere” in quel paese-prigione. Una parentesi di intensa poesia, che rappresenta il momento più alto di una sceneggiatura eccellente e puntellata di altre inquadrature e sequenze memorabili.
A partire da quella iniziale, con il silenzio che scandisce il frettoloso pranzo della famiglia del notaio Ferulli, in cui i genitori e i quattro figli non si scambiano una sillaba e neppure uno sguardo. O la ripresa dall’alto, lungo le strade del paese, dell’appostamento di uno dei tre protagonisti, Francesco (Stefano Satta Flores), per avvicinare Anna (l’attrice Rosanna Santoro), la ragazza di cui si è invaghito. O, ancora, la disperata e frenetica fuga in circolo tra i grossi covoni di grano di Cecchina, come posseduta da un terrore misterioso, in realtà ancora scossa per le molestie subite dal guardiano del cimitero.

In questo scenario, la luce di un pensiero critico vive soprattutto nella figura di Maddalena (Enrica Chiaromonte): una ragazza di condizione umile, disincantata ma non remissiva, al punto da attivarsi per la costituzione di una cooperativa di piccoli proprietari in una comunità dominata da un individualismo esasperato e da una sorda rivalità nell’élite dei benestanti, e tra questi e la massa dei contadini poveri.
Maddalena è il vero polo positivo della storia, l’unica “voce di dentro”, ironica e saggia, che la Wertmuller – con una chiave narrativa che al critico dell’‘Avanti!’ Lino Miccichè apparve “discutibile” e invece si rivela originale e brillante – investe del ruolo di voce narrante fuori campo, illustrando la vita della sua comunità con un linguaggio di sorprendente realismo.
“Tutti laureati, e rimanete tutti qua…Questa è una morte lenta”, è una delle riflessioni più lucide che le affida la regista. E terribilmente attuale.