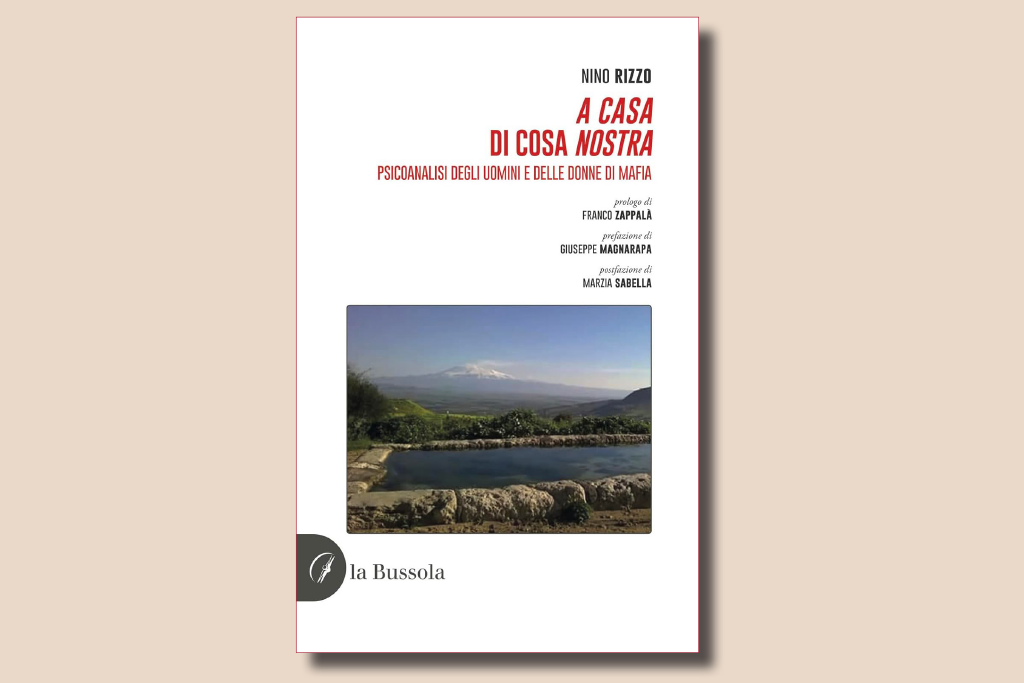«L’uomo mafioso è un perverso fragile»
Il padre, capo mafia, venne arrestato dal giudice Falcone. Nel suo libro «A casa di Cosa nostra», oggi tradotto in francese, Nino Rizzo, noto psicanalista di Ginevra, si avvale del vissuto personale all’interno di una famiglia mafiosa e ci fa capire come funzionano gli uomini di mafia, con il sostegno discreto ma essenziale delle donne.
Di Guido Gozzano 25 febbraio 2025
A vent’anni «fugge» dalla Sicilia, approda a Ginevra, studia psicologia all’Università, e diviene uno dei più noti professionisti della città. Nino Rizzo (foto), figlio di Matteo, capo mafia di Ramacca, in provincia di Catania, alla morte del padre decide di scrivere un libro nel quale è psicoterapista di sé stesso, e degli uomini e delle donne di mafia. A casa di Cosa nostra (La Bussola, 2023), tradotto in francese con il titolo La Mafia sur le divan, riavvolge il personale nastro del tempo e racconta, cioè analizza cosa c’è nell’animo di un mafioso, facendo luce sugli angoli più oscuri.
Qual è il profilo psicologico del mafioso?
Nino Rizzo: È il profilo della perversione, ma l’uomo mafioso è un perverso fragile. Il perverso, a tutti i livelli, sessuale o sociale, è qualcuno che pervertisce, inverte l’ordine delle cose. Il perverso sessuale per esempio, anziché assumere il proprio desiderio, attribuisce all’altro il desiderio che non riesce ad assumere: tu mi vuoi, tu mi desideri. Il perverso sociale attribuisce all’altro un bisogno di sottomissione. L’uomo mafioso fa lo stesso: tu mi paghi il pizzo, l’imposta mafiosa, perché tu hai bisogno della mia protezione; tu ti sottometti perché vuoi che io ristabilisca e garantisca la giustizia.
L’uomo mafioso è perverso, ma è anche «fragile». Che significa?
Poco prima di morire mio padre mi parlò con le lacrime agli occhi della madre, morta quando era bambino. In un certo qual modo, nel profondo della sua anima, è rimasto un bambino aspettando il ritorno della mamma. Era un uomo tenero, generoso, buono. L’assurdità è che questi uomini, pur capaci di uccidere e fare stragi, sono esseri umani dotati di affetto. Per noi, figli di mafiosi sfuggiti alla mafia, è molto difficile, spesso impossibile accettare la duplice valenza dei nostri padri, soprattutto quando mostrano la loro fragilità.
È questa fragilità che, per così dire, fa cascare molti uomini fra le braccia della mafia?
Assolutamente. Questi uomini si sono costruiti, si sono inseriti nella società con una fragilità emotiva profonda. Hanno trovato una «seconda famiglia» in quella mafiosa, che ha dato loro una parvenza di solidità umana e sociale. Questi uomini, quando sono soli, fuori dalla famiglia mafiosa, sono smarriti. Nel caso di mio padre, la fragilità era determinata dal trauma dell’infanzia, la perdita della madre. Se si scava, probabilmente, si scopre che questo tratto è comune a tutti, o alla maggior parte dei mafiosi. Questi traumi prendono forme diverse a seconda del contesto sociale, e quello siciliano si presta molto bene ad assumere questi ex bambini traumatizzati e a farne dei delinquenti, dei mafiosi. Un contesto contrassegnato altresì dalla violenza.
Come spiega la persistenza, in Sicilia, di una forte dimensione di violenza?
Uno dei proverbi siciliani più popolari è Calati juncu ca passa la china, cioè «piegati giunco poiché il fiume scende in piena», un detto che esprime lo spirito degli abitanti dell’isola, per secoli «piegati» al giogo dell’oppressore, e per questo capaci di una grande «resilienza». Ma quando il fiume passa, il giunco si rimette dritto e in quel movimento scarica la sua violenza. Così da sempre funzionano i siciliani.
Il libro apre uno squarcio sul ruolo discreto e essenziale delle donne. Come funziona?
Le donne garantiscono un supporto al mafioso, di cui lo stesso mafioso ha bisogno, anche se non lo ammetterà mai. Ha bisogno dell’ammirazione delle donne, e di tutta la famiglia, cosa che gli dà una sorta di cauzione morale: che quel che fa è buono e giusto. Ora quando un figlio si ribella, per un padre mafioso è insopportabile. Il film I cento passi, racconta la tragica vicenda di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia nel 1978. Era stato cacciato di casa dal genitore, determinando in un certo senso la sua condanna a morte.
Come si sfugge ai tentacoli della famiglia mafiosa? Basta andare all’estero, come ha fatto lei?
Avevo 25 anni, mio padre mi raccontò un segreto di mafia, che non fu più un segreto quando Antonino Calderone, pentito di mafia di Catania, cominciò a collaborare. Mi confessò che il figlio di un capo mafioso di Caltagirone fu fatto ammazzare dal proprio padre, perché aveva detto cose che «non doveva dire». Con questa allucinante vicenda mio padre mi fece capire che dovevo fare molta attenzione. Decisi allora di ritirarmi da quel mondo, e lo feci in punta di piedi. Non ho mai parlato di mafia fino alla morte di mio padre, soltanto dopo ho scritto il libro. Ho atteso che tutti i mafiosi dalla famiglia di Ramacca fossero deceduti, prima di pubblicarlo. Un modo per sfuggire alla mafia è sì andare all’estero, ma con la massima prudenza e con profondo rispetto.
Qualcuno ha letto il suo libro a Ramacca?
Qualche raro, rarissimo personaggio che pensa, riflette e non accetta la situazione che vede la mafia essere padrona del destino della gente. Nella mia famiglia, credo lo abbiano letto tre donne, che fanno però parte della famiglia acquisita. Nessun uomo lo ha letto.
Qual è stata la ricezione del libro, oltre la sua famiglia, nel paese di Ramacca?
La reazione quasi unanime, a parte rarissime eccezioni, è stata questa: ma chi glielo ha fatto fare, perché tutto questo fango sulla sua famiglia, sul paese, sulla Sicilia? È la prova che non hanno letto il mio libro, in cui ne parlo con molta umanità, e cerco di dire che i mafiosi della mia famiglia, del paese, sono comunque degli esseri umani.